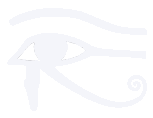di Silvia Rossetti e Michele Rucco
“Il danno scolastico”: così il sociologo Luca Ricolfi e la scrittrice Paola Mastrocola intitolano la loro recente fatica editoriale. Un libro aspro che descrive “una scuola progressista come macchina di disuguaglianza”, in quanto, secondo gli autori, una scuola di bassa qualità, apparentemente pensata per dare accesso anche ai più fragili, in realtà annega le speranze proprio di questi ultimi che non hanno altri mezzi diversamente da chi ha più possibilità economiche e più risorse sociali e culturali.
E, sempre secondo loro, ciò è frutto della cultura progressista che si è battuta per la democratizzazione della scuola, intesa non come “mettere la cultura alta a disposizione di tutti”, ma come “diritto al successo formativo”, con conseguente abbassamento proprio degli standard formativi: tutto ciò ha aumentato, non ridotto, le diseguaglianze sociali, in quanto è venuto meno il funzionamento del cosiddetto ascensore sociale, permesso dall’aver ricevuto un’ottima istruzione.
Stupisce che un’ex insegnante e perfino un sociologo propongano un testo che pare strizzare l’occhio a un modello di scuola che appariva obsoleto già negli ultimi scorci del secolo scorso e intenda, in maniera piuttosto approssimativa e per certi versi strumentale, attribuire la responsabilità del degrado culturale che attualmente colpisce la nostra società alla scuola degli ultimi decenni, che loro definiscono ideologizzata e sinistroide.
In questa ricostruzione i docenti, o almeno gran parte di loro, vengono etichettati quasi come falsari, avvezzi a certificare nei ragazzi competenze inesistenti e a varare intere generazioni di abissali ignoranti. Nella migliore delle ipotesi vengono visti come marionette di un sistema descritto come bacato.
Si parla di “asticella delle richieste che si abbassa e accresce di conseguenza le diseguaglianze” e di scuola “indulgente”, che attraverso un falso processo di democratizzazione avrebbe inferto un duro colpo sia alla reale costruzione di una futura classe dirigente, sia ai ceti meno abbienti illudendoli con titoli privi di consistenza.
Messo in questi termini il processo intentato dai due autori si trasforma facilmente in una condanna priva di appello, ma la narrazione dei fatti appare alquanto semplificata. Quanto meno dimentica (o volutamente nasconde) che la scuola italiana era fortemente selettiva: ancora nel 1984, secondo i dati Istat, si iscriveva alle scuole superiori soltanto il 55% degli studenti licenziati dalle medie, e di questi, un ulteriore 25% poco dopo abbandonava il percorso di studi. Diversamente, oggi, pressoché il 100% degli studenti esce dalle medie e si iscrive a una scuola superiore (dal liceo all’istruzione professionale).
L’unica affermazione forse condivisibile è che la scuola, soprattutto quella del segmento dell’obbligo, abbia frainteso, come molte altre agenzie della nostra società, il concetto di modernizzazione soprattutto negli ultimi anni, non riuscendo a interpretare correttamente il cambiamento e a stargli al passo. Puntando molto su progetti e innovazione, disperdendo in parte energie preziose e sottovalutando l’impatto corrosivo che un certo tipo di comunicazione mediatica arrecava e arreca al substrato culturale collettivo.
In una società che cambia la scuola non può restare immobile dispensatrice di paginette da studiare, credo che su questa affermazione possiamo tutti convenire. Come pure sul fatto che in un panorama dove la mole delle informazioni fruibili e in circolazione è gigantesca, non si può continuare a impostare il lavoro scolastico come mera meccanica trasmissione di nozioni, perché oggi sono sufficienti un paio di clic per avere a disposizione una quantità incredibile di materiali con cui riempire i nostri scaffali interiori.
In questa società che in meno di trent’anni ha profondamente modificato i ruoli all’interno del nucleo familiare, i ritmi lavorativi, e quindi vitali, e che è stata investita da una rivoluzione tecnologica pervasiva e complessa, un sociologo e una insegnante puntano il dito sulla scuola perché questa non crede più che l’apprendimento coincida con la “risposta esatta” al quiz di turno.
Diversamente, il pedagogista Daniele Novara, nella sua opera “Cambiare la scuola si può”, denuncia che da almeno cento anni la scuola italiana è impostata allo stesso modo; evidenzia che, nonostante le continue riforme e i vari tentativi di digitalizzazione, lezioni frontali, compiti a casa, studio mnemonico continuano a essere al centro della didattica, e sottolinea che “insegnanti e studenti considerano che l’educazione abbia avuto successo quando gli studenti sono in grado di fornire le risposte accettate come corrette. Naturalmente, alla lunga, non si tratta di una transizione felice: finché si accettano prestazioni rituali, meccaniche o convenzionali, non si promuove la comprensione autentica”.
Lo studioso di converso afferma che “Il concetto di esatto e di sbagliato va ridefinito alla luce delle nuove conoscenze sull’apprendimento che insistono sulla sua natura operativa più che mnemonica.
La vera valutazione dell’apprendimento va costruita su situazioni complesse, compiti problematici che necessitano di una dimensione di utilizzo plurale delle intelligenze ma anche di collaborazione e cooperazione tra gli alunni.
Si tratta di predisporre occasioni di lavoro e di ricerca che consentono agli alunni di mettersi alla prova senza lo stress del giudizio e della competizione con gli altri; prove su esperienze che calano gli alunni nella loro vita reale”.
In conclusione ciò che viene definito “abbassamento dell’asticella” corrisponde a un percorso che prende in carico il discente nel suo percorso evolutivo e non semplicemente nella performance del momento, un percorso che guarda all’uomo e al cittadino e non soltanto all’alunno diligente che conosce a memoria la lezione.