Le Virgole, un appuntamento estemporaneo fra chi ama scrivere e chi ama leggere.
Scriverò dell’unica cosa del mio passato che continua a condizionare la mia vita perché, pur essendo quotidianamente presente intorno a me, è da sempre assente nella mia vita.
Non ricordo se fosse stata mia madre a comprarla o se le fosse stata regalata da mio padre; ricordo benissimo, invece, la prima volta che la sua presenza -all’epoca non avevo idea di che cosa avrebbe significato la sua assenza- si scontrò con la realtà di me bambino.
Il fatto accadde quando avevo otto anni, precisamente sette giorni prima della Pasqua.
A quel tempo mia madre era preda dell’euforia di cucinare i tipici dolci della festività, ed era sua abitudine prepararne una quantità notevole per distribuirne a sua madre, alle tre sorelle, a una famiglia del vicinato e al pediatra che aveva in cura i suoi sei figli, me compreso.
Sapendo che le uova delle nostre dieci galline non le sarebbero bastate, ne comprava altre dai contadini confinanti in modo da averne la quantità sufficiente per impastare i taralli, la pasta frolla e il ripieno per le dodici -e forse più- pastiere da distribuire tre giorni prima della ricorrenza. Uova freschissime deposte dalle galline che razzolavano e svolazzavano sul campo accanto alla stalla e che mi divertivo a spiare, ogni qualvolta andavo a comprare il latte.
Nell’attesa di raggiungere il numero adeguato, giorno dopo giorno, aggiungeva con cura, una dopo l’altra, quel centinaio di uova dentro un grande cesto di vimini, e lo posizionava, non prima di averlo ricoperto con la carta del pane stropicciata, in modo da proteggerle ulteriormente, sopra il grande armadio della camera da letto, per tenerle lontano dai giochi pericolosi di noi bambini e ragazzini vivaci.
Quell’armadio, enorme, come la camera da letto dal soffitto altissimo a spiovere, era di noce massiccio, a sei ante e alto non meno di tre metri. Ogni due ante c’erano delle sottili colonne con capitelli corinzi che mi divertivo a girare per ascoltare lo stridore che il legno, sottoposto a frizione, produceva.
Credo fosse un sabato quando successe ciò che poteva essere evitato se solo non avessi avuto quell’indole buonista, opposta a quella dei miei fratelli.
Quel mattino festivo mi svegliai più tardi del solito e, assonnato, mi recai in cucina a fare colazione. Aprii la porta e guardai il piano del tavolo con molte pastiere e un bel po’ di teglie con i taralli, tutte pronte per essere portate al forno a legna del vicino contadino per la cottura.
Mi distolse il grido di mia madre, lo stesso che, forse, mi aveva svegliato:
– Le uova Giovà, prendi tutto il cesto da sopra all’armadio che abbiamo appuntamento col forno tra quaranta minuti.
Alzai lo sguardo e vidi mia madre curva sulla madia, quasi sospesa tra due sedie, intenta a versare farina. I nostri sguardi s’incrociarono e ci sorridemmo felici di specchiarci l’uno nell’altra. Ero l’ultimo dei figli, venuto dopo diversi anni dal precedente, e questo ci aveva particolarmente uniti.
– Enzuciell’ e vist’ mammà che bei dolci che fa’, per te ho fatto quei taralli a forma di cuore, pecch’ tu sii a vita mia…
Volevo aiutarla e andai a chiamare Giovanna nella sua stanza: la trovai alla finestra che amoreggiava col figlio del vinaio, un suo giovane spasimante. Le riportai la richiesta di nostra madre, ma lei ignorò anche me.
A questo punto emerse la mia inclinazione altruista, per cui decisi di farlo io.
Mi recai nella stanza da letto e accostai una seggiola all’armadio.
Mi alzai in punta di piedi, ma non riuscendo a raggiungere la sommità dell’armadio ridiscesi e appoggiai sulla sedia due scatole di scarpe e ci salii sopra.
Mi affacciai e a malapena riuscivo a scorgere le uova, ma restai di sasso quando, da dietro il cesto, misi a fuoco una testa che mi fissava ciecamente: muta in quel sorriso beffardo che emergeva tra i denti bianchi e le labbra rossissime.
Mi spaventai e sentii le punta dei miei piedi tremare sulle scatole, già instabili di loro; in cerca di un appiglio mi aggrappai al cesto e, in un baleno, mi ritrovai a terra ricoperto di albume e tuorli d’uova, con negli occhi la persistenza di quel sorriso beffardo.
Il botto fece accorrere mia madre e subito dopo mia sorella che iniziò a ridere vedendo albumi e lacrime fondersi nel rosso dell’uovo. Mia madre, spaventata, mi rincuorò e subito dopo diede una sberla alla primogenita dandole la colpa dell’accaduto.
– Giovà così impari, tu stai sempre alla finestra a fare le moine con Giacomo, quando torna tuo padre glielo dico, accusì t’accir’ e mazzat’.
Si chinò su di me e col grembiule mi pulì il volto, poi mi disse di non preoccuparmi, che tutto sommato mi era andata bene perché non mi ero fatto male. Mi strinsi a lei piangendo e farfugliando le dissi che avevo cercato solo di aiutarla. –Enzucchiell’ tu sii tropp’ buono, nun va ben’ accussì. La prossima volta dillo a me che cosa vuò fa’, va bene?
Annuii ma non smettevo di piangere, tra l’altro il nomignolo che i miei fratelli mi avevano dato era trumbtell’, perché secondo loro frignavo sempre, anche senza ragione.
In quell’occasione piangevo perché mi sembrava di aver già vissuto quell’episodio.
Già altre volte da bambino mi ero reso conto che la realizzazione del mio desiderio di soccorrere gli altri si rivoltava contro di me ed io restavo da solo in balia delle inaspettate conseguenze. Devo ammettere che questa mia indole di far disastri ce l’ho ancora adesso e si è ripresentata in più occasioni.
La colpa è della mancanza di quella cosa che, vi sembrerà strano, anche adesso che scrivo sto fissando: ferma davanti a me, su una mensola.
Oggi non mi spaventa più, anzi è la cosa che più amo del mio passato perché carica di ricordi, anche se lei non si rammenta mai di me. La sua mancanza è l’unico dato certo del mio vivere ansiogeno, probabilmente si tiene alla larga perché anche lei teme la mia bontà d’animo.
Quella cosa è una ceramica smaltata degli anni Cinquanta e rappresenta la Dea fortuna, con la capigliatura tipica di quegli anni, con gli occhi bendati da una fascia d’oro e con le labbra di un rosso vivo aperte in un lieve beffardo sorriso.
Nato in una famiglia allargata, penultimo di nove figli, all’inizio della primavera del 1957, dopo il Liceo Artistico di Napoli e il corso di scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, Crescenzo Zito si iscrive alla facoltà di Lettere Moderne dell’Università La Sapienza di Roma e tre anni dopo passa a Psicologia, che abbandona lo stesso anno per uno psicologo. Ha iniziato a lavorare prestissimo presso varie Amministrazioni, nel frattempo dirige tre cortometraggi; scrive un paio di monologhi teatrali, tre raccolte di racconti e un centinaio sparsi, di cui una quarantina pubblicati in antologie, a Roma e a Milano; fotografa centinaia di persone borderline, sfiorando la loro esistenza. Di se stesso dice: “Ciò che ho intimamente vissuto non è cesellabile e le mie tappe passionali sono tantissime e non tutte raccontabili”.
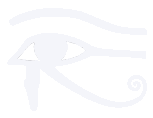

Un racconto di straordinaria e pulsante vitalità. C’è dentro il seme di mille altre storie.