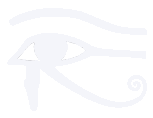Le Virgole, un appuntamento estemporaneo fra chi ama scrivere e chi ama leggere.
Era un abito blu. Era un vestito lungo, elegante: sarà costato una fortuna. Precisamente era blu notte, ricoperto di paillettes e di ricami. Era proprio un bel vestito. Era un meraviglioso ed elegantissimo vestito blu piegato con cura su una sedia. Lo guardavo, lo osservavo… Era la prima cosa che vedevo quel giorno: ho aperto gli occhi e c’era lui, il vestito blu.
Boh.
Era una camera carina, arredata con cura: i muri giallo ocra, un armadio grande, bianco, aperto, dentro vestiti piegati a modo, ordinati con premura… un enorme comò antico, non so di che legno… non me n’è mai fregato un cazzo del legno dei mobili…la gente è ossessionata dal legno dei mobili…
Io no.
C’era uno specchio di fronte a me, nello specchio la mia immagine riflessa: io, seduto su un letto a due piazze, un bellissimo piumone completamente accartocciato, la mia faccia, la faccia di chi ha esagerato, di chi ha decisamente bevuto, le labbra nere di vino, i capelli fuori controllo, vestito con una canottiera, un calzino addosso, l’altro chissà dove.
Non so dove.
C’era il sole fuori, era una bella giornata. C’era il sole e il silenzio. Ma non era proprio un silenzio… C’era un rumore, leggero, lontano, rassicurante. Era caffè: lo sentivo uscire lentamente nella caffettiera, sentivo lentamente il suo profumo.
Ci vorrebbe un caffè.
Ricapitoliamo: c’era il vestito blu, c’era la camera carina, c’era il comò di legno, c’era il caffè.
C’era un passaggio che mancava, c’erano pensieri, c’erano dubbi…
Perché ero lì? Perché quella camera non era la mia? Di chi era quella camera?
Attanagliato da questi pensieri, sedotto dall’odore di caffè, stropicciandomi gli occhi gonfi, raccattai i miei vestiti. Li trovai quasi tutti, tranne il calzino. Era il sinistro quello mancante.
Non sapevo dov’ero, non sapevo perché ero lì e non trovavo il calzino.
A un certo punto un Jack Russel entra veloce nella stanza, scodinzola e freme come un idiota, vuole giocare, col mio calzino in bocca.
Lui era Gino.
Non sapevo dov’ero, non sapevo perché “ero”, ma sapevo che lui era Gino.
Dopo un po’ ricordai: era una festa, bella, sfarzosa, di quelle che di solito non ti invitano, di quelle che quando capitano sei felice, perché sai che poi non capitano più. Di quelle di gente ricca, che ti puoi vestire elegante. Di quelle che sei felice di esserci ma dopo un po’ se non bevi sei finito. Se non bevi hai voglia di iscriverti all’Isis, di farti saltare in aria. Era una festa bellissima ma io mi annoiavo tantissimo. Anche lei si annoiava tantissimo. Lei era tantissimo. Lei era tantissimo grande, grassa. Non troppo. Abbastanza da renderla goffa. Indossava un vestito. Era un cazzo di vestito blu. Erano come due elegantissimi e costosissimi abiti blu, attaccati l’un l’altro per farci entrare Marica, compressa, sotto vuoto. Mi parlava di Gino, del suo Jack Russel. Pensavo che fosse il suo unico amico. Pensavo che ero nella sua stessa condizione. Nella stessa situazione. Ero IO, ero magro, ero carino quella sera, ma ero come Marica, solo, ma senza Jack Russel.
Pensavo a Lei…
A quell’altra ovviamente. Pensavo a lei che fuma una sigaretta. Com’era bella. Mi serviva del vino. Per non pensare a lei.
Bevvi una mezza bottiglia di vino. Non è un’unità di misura. L’ho inventata io. Una mezza bottiglia di vino. Come se fosse un tipo di bicchiere. Come se a IKEA ci fossero i bicchieri da mezza bottiglia di vino. Come se senza sarei esploso. Avevo paura. Di esplodere. In lacrime, sul decolleté di quella grassa ragazza. Gridando il suo nome. Non quello di Marica. Bevvi quel vino, bello, costoso, di quelli che non compri, di quelli che non puoi. Di quelli buoni. Bianchi, col ghiaccio e l’etichetta stronza.
La ascoltavo. Lei non era abituata a questo. Credo fosse eccitata solo perché qualcuno la stesse ascoltando. Bevvi un’altra mezza bottiglia di vino. Non è carino non completare le bottiglie di vino. Sicuro qualche nonno alcolizzato insegna ai nipoti che non si lascia una mezza bottiglia di vino così, è da maleducati. Pensai questa cazzata. Mi faceva ridere. Ero chiaramente brillo. Perché era troppo una cazzata.
Andai da Marica e le dissi: “Voglio giocare col tuo cane”. “Ma è a casa mia?”. “Come si chiama?” “Chi?” “IL CANE” “Gino.” “Voglio giocare con Gino.”
Marica Marica…
Poveraccia…
Non ho mai visto tanta tristezza.
Non ho mai visto tanta felicità.
Ho visto queste due cose in lei.
La felicità di chi riceve un invito e non ci è abituato.
La tristezza di chi è solo.
Quella che vedo nella mia faccia, riflessa dallo specchio.
La tristezza di chi si guarda allo specchio mentre prova a strappare il calzino dalle fauci di Gino. Facevo una cosa che faceva rima. Era un cane di merda Gino. Completamente idiota. “Ho scopato con lei Gino. Ridammi il calzino, me ne devo andare.”
Non sono felice Gino. Non voglio il suo caffè. Non voglio i suoi sorrisi, non voglio i tuoi giochi Gino. Lasciami in pace Gino.
Lasciò il calzino.
Grazie.
Dovevo scappare. Non volevo farla star male. Era una ragazza troppo triste. Pensai che l’avrebbe uccisa la mia fuga. Presi una foto. Una foto che aveva sul comodino. Una sua foto.
Com’era brutta.
Girai la foto. Presi un pennarello fucsia, ce l’aveva sul comodino. Scrissi sulla foto: grazie. Sono stato proprio bene.
Guardai Gino. Lui mi guardava. Voleva giocare. Io lo odiavo. Gli diedi uno schiaffo. Tanto non c’era nessuno. Non troppo forte. Però capì Gino. Gino capì. E io me ne andai. Con quell’aria da stronzo. Con quell’angoscia nel petto.
Con quell’immagine in testa. Bellissima. Di lei. Che fuma una sigaretta.
Ci vorrebbe una mezza bottiglia di vino.
Armando Quaranta (1989) è un attore, drammaturgo e regista teatrale romano di origini pugliesi. Ha recitato in film di Guido Chiesa, Riccardo Milani e Alessio Maria Federici e ha portato in scena diversi suoi spettacoli a Roma, nel Lazio, in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna. Questo suo racconto è pubblicato nella raccolta “Era un abito blu” curata dalla Libreria Mondadori di Via Piave Roma.