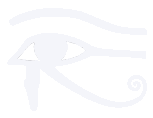Ormai da mesi per ciascuno di noi la giornata si chiude con una preghiera, non importa se rivolta a una divinità o se affidata allo spazio sconfinato dell’universo. Una preghiera che ha molti nomi. Speranza. Illusione. Desiderio. Volontà.
Come una monetina, può essere lanciata con un gesto rituale. È capace di attraversare la notte e depositarsi, assieme a tutte le altre, sulla soglia del giorno seguente, ai confini di quello cui diamo il nome di futuro.
Vorremmo tutti che l’incubo pandemia finisse e che la vita riprendesse com’era prima, o se possibile meglio ancora, arricchita della consapevolezza di chi ne ha sofferto profondamente la mancanza.
Sono intessute di propositi e di bilanci le nostre preghiere. Ciascuno conosce bene le proprie parole e la melodia del proprio canto. Ma la trama è per tutti impregnata in un unico bagno di colore, quello della nostalgia. “La nostalgia è una sofferenza fragile e gentile, essenzialmente diversa, più intima, più umana delle altre pene. È un dolore limpido e pulito, ma urgente”, ci ricorda Primo Levi quando nel romanzo “La tregua” parla del “ritorno”.
Il primo a raccontarci la nostalgia è Ulisse, anche se non sono stati i greci a coniare questa parola. A definirla fu un giovane studente di medicina, l’alsaziano Johannes Hofer, che nel 1688 la descrisse in termini clinici, constatando le sofferenze dei mercenari svizzeri al servizio di Luigi XIV, costretti a stare per lungo tempo lontani dai monti e dalle vallate della loro patria.
Nel nostro caso la nostalgia non riguarda però un luogo, ma un tempo.
Il tempo ha una sua circolarità, si sa. Tende a ripetersi quasi uguale a se stesso. Nel lanciare la nostra monetina dei desideri siamo sorretti da quest’unica certezza: “Passerà”.
Chissà se, “passando”, riuscirà a fecondare la nostra esistenza di nuovo vigore.
Tra le frasi fatte di questa pandemia ascoltiamo parole come ri-partenza, priorità, autenticità, progettualità, solidarietà. Forse ne manca una, all’appello. O meglio, manca che i fili delle parole dette costituiscano l’essenza del prossimo prototipo di uomo, dell’uomo post-pandemia.
Ulisse si finse pazzo per non partire alla volta di Troia, così spogliandosi della propria identità di re. Al suo ritorno, dopo mille peripezie e tentazioni, l’ultima prova riguardò proprio (e di nuovo) la sua identità: il confronto con la sua sposa, Penelope.
La parola mancante, dunque, forse è proprio “identità”. Saremo capaci di trasformare la nostra nostalgia in uno struggente commiato con un tempo che ormai abbiamo superato nel nostro viaggio? Saremo capaci di diventare “altro”, rispetto a quello che siamo stati?
“L’uomo solo si leva che il mare è ancor buio e le stelle vacillano”, scrive Pavese descrivendo il risveglio dei pescatori. Quando l’ultimo “steddazzu” (stella in dialetto calabrese) abbandona il cielo, “l’uomo adagio prepara la pipa e l’accende”.
È l’alba del futuro.