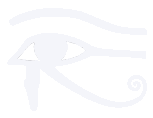Indice
La crisi dei soggetti
Gli sconvolgimenti sociali e politici della Grande Depressione del 1929 e lo sfacelo causato dalla guerra contro Hitler ebbero un profondo effetto sui giovani artisti in Europa e in America. La generazione che iniziò a dipingere negli anni Trenta e agli inizi degli anni Quaranta del secolo scorso era in uno stato d’animo disperato: le premesse ideologiche e le logiche del cubismo avevano perduto il loro fascino, la crisi dei soggetti da rappresentare era così grave che gli artisti si sentivano liberi di dipingere qualsiasi cosa per quanto potesse sembrare assurda.
Molti pittori si concentravano sull’atto stesso del dipingere basandosi su un principio che era già ben radicato: svuotare le menti dai preconcetti e applicare il colore con la massima spontaneità, in questo modo le immagini prodotte sarebbero state un’espressione degli strati più profondi del loro essere.
L’arte come mezzo di autopercezione
L’arte diviene così un mezzo di autopercezione. Già i surrealisti avevano mostrato la strada formulando la tecnica dell’automatismo psichico, secondo la quale il pittore opera alla cieca. La moderna psicologia del profondo sembrava indicare che la mente può esercitare un’autorità repressiva sull’inconscio e che, se si fossero liberate della sua presa, le fonti dei sentimenti avrebbero ripreso a scorrere liberamente. Gustav Jung mostrò agli artisti che l’arte primitiva era una fonte vergine di simboli rilevanti anche per il mondo contemporaneo. Jean Paul Sartre offrì poi una base teorica a questo orientamento, permettendo agli artisti di acquisire fiducia in se stessi e nel proprio lavoro: per l’esistenzialismo, infatti, “l’essenza è fare”, dando con questo la giustificazione intellettuale ad un approccio che enfatizza il “PROCESSO” a scapito del “PRODOTTO” e che quindi, come pensarono successivamente gli artisti della scuola di New York, ciò che doveva andare sulla tela non era un quadro ma un “AVVENIMENTO”.
La scuola di New York
Il mondo artistico nordamericano si trovò a subire contemporaneamente sia la crisi di valori sia la crisi economica: fu aiutato dal programma del governo federale, che, nell’ambito del New Deal voluto da Roosevelt, a partire dal dicembre 1937 stipendiò con 95 dollari al mese per 96 ore di lavoro ben 3.749 artisti. Realizzarono 25.643 opere per istituzioni e spazi pubblici e, soprattutto, permisero la sopravvivenza di uno spazio vitale per l’arte.
La seconda guerra mondiale vide emigrare dall’Europa grandi artisti per sfuggire al nazismo e al fascismo, tra cui Breton, Chagall, Ernst, Leger, Masson, Matta, Mondrian, Arschile Gorky e tanti altri.
Così negli anni Cinquanta, la capitale dell’arte si sposta definitivamente da Parigi a New York ed è proprio lì che nasce una scuola di pittori, tutti americani, tutti piuttosto giovani, che ‘riformano’ la pittura astratta: Jackson Pollock, Mark Tobey, Willem De Kooning, Robert Motherwall costruirono immagini basate su forme biomorfe collegate a strutture vegetali e animali, a simboli primitivi, a modelli seminconsci dell’automatismo; Mark Rothko, Clyfford Still, Barnett Newman, invece, sono più interessati al colore e non al segno.
Per tutti loro, le dimensioni delle tele usate erano enormi, e questo era un elemento fondamentale per il tipo di pittura praticato, in quanto le tele molto grandi alteravano il rapporto dello spettatore con l’opera, egli non era più in grado di contenerla o di racchiudere il quadro in un solo colpo d’occhio. Inoltre, gli oggetti di grandi dimensioni incutono soggezione, si confanno alle aspirazioni trascendentali di Rothko e di Newman che usarono i “campi di colore” come una affermazione del mistero dell’essere.
I campi di colore di Rothko
Ebreo nato in Russia nel 1903 emigrato a 10 anni in USA, a partire dal 1945, dopo anni di sperimentazione surrealiste, abbandona la pittura con forme umane e animali e si concentra su quelli che sino ad allora erano solo i fondi su cui dipingeva: passa a costruire stesure monocrome rotte da due o tre forme rettangolari dai margini sfumati accatastate le une sulle altre.
La tavolozza di Rothko è morbida e luminosa, sensuale. Sottili veli di colore sfumano la tela e la impregnano, colori caldi si sovrappongono a quelli freddi, quelli freddi ai caldi, il colore scuro si sovrappone al chiaro e viceversa. Sebbene le composizioni di Rothko si possano spezzare in componenti distinte egli riuscì a conservare la integrità del “campo”. Non c’è un punto centrale di attenzione. I suoi rettangoli riempiono il quadro, la cui forma ripetono e confermano.
L’intensità contemplativa
I campi colorati hanno una intensità contemplativa e invitano a una resa dell’io. L’atmosfera delle opere mature come “Rosso bianco e marrone” del 1957 è passiva e meditabonda: opache nebbie di colore smembrato invitano lo spettatore in uno spazio tranquillo, equivalente metaforico del sogno. I rapporti cromatici tra le zone danno la sensazione che gli spazi avanzino o arretrino e le parti chiare assumono aspetti di bagliori e di TEOFANIE, cioè apparizioni divine attraverso la luce.
Rothko non era interessato ai rapporti tra forma e colore, gli interessava solo esprimere emozioni umane fondamentali, quali “la tragedia, l’estasi, il destino”; sosteneva che “il fatto che la gente pianga di fronte ai miei quadri vuol dire che mostra la mia stessa esperienza religiosa che ho vissuto io dipingendo” e che quindi era riuscito ad ottenere quello che si prefiggeva. Diceva: “La mia arte è l’espressione semplice di un pensiero complesso”.
Il tempo non esiste nelle tele di Mark Rothko e questa sorta di eterna stasi accompagna verso l’infinita testimonianza della tragedia del nascere, vivere e morire. Questi dipinti sono da sempre considerati indecifrabili, a volte persino incomprensibili, ma in realtà sono dotati di un significato profondo: la necessità di raggiungere la più pura chiarezza espositiva ha reso Rothko un maestro sia artistico sia spirituale. I suoi quadri sono pura esperienza di contemplazione.


Il suo lavoro avveniva in un grande studio a luci molto basse; un lavoro lento, si sedeva fumando una sigaretta dietro l’altra, guardava la tela e ogni tanto si alzava a dare pennellate meditate a lungo, per costruire le diverse intensità tra le bande, con una cura esecutiva smisurata che si risolveva in una sintesi estrema.
Rothko non mutò questa sua cifra stilistica, ma nella seconda metà degli anni 50 la sua tavolozza divenne sempre più cupa, più luttuosa, profonde tonalità di porpora abbinate al rosso sangue, marroni mescolati a verdi smorti, per poi passare alle tonalità di viola scuro e nero. Come in “Nero su grigio” del 1970 e altre che sono cupamente pessimistiche. Nel 1970, fisicamente logorato dal fumo e dall’alcool, con una vita segnata dalla depressione, si suicidò nel suo studio.
La Cappella Rothko
Nel 1964 la coppia di magnati texani Dominique e John De Menil gli chiesero di dipingere una serie di quadri per una cappella aconfessionale che volevano costruire a Houston: Rothko accettò e dall’autunno del 1964 alla primavera del 1967, dipinse quattordici grandi dipinti e quattro sostitutivi, enormi tele dove il colore nero incorpora altre sfumature scure ed effetti tramati. Quando la cappella fu inaugurata nel 1971, con Rothko morto suicida l’anno prima, le otto pareti furono arredate con le quattordici tele: tre delle pareti contengono dei trittici, mentre le altre cinque ospitano dipinti singoli. L’insieme crea un’atmosfera inquietante, resa ancora più cupa dal fatto che è illuminata solo da luce naturale che filtra da un lucernario.

La spiritualità dei dipinti ha ispirato il musicista Peter Gabriel che, dopo la sua esperienza nella Cappella Rothko, ha intitolato una delle sue composizioni Fourteen Black Paintings, dedicandola ai diritti umani e civili. Il brano può essere ascoltato qui di seguito.