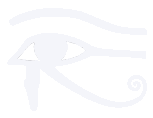di Silvia Rossetti e Michele Rucco
Prima della violenza, in genere c’è la solitudine.
Può essere la solitudine momentanea di una strada poco battuta di notte, oppure dell’androne di un palazzo in mezzo al degrado di qualche periferia; può essere la solitudine di un viale della villa comunale da attraversare per fare presto o dell’androne di un centrale palazzo signorile ove ognuno è chiuso nel suo cerchio magico sordo al mondo esterno. In questi casi la solitudine è soltanto una circostanza, una condizione che facilita un reato magari improvvisato, quindi non premeditato, un raptus bestiale che si scaglia contro la sventurata di passaggio, sola e colpevole di essere donna.
Perché quando intorno è buio o desolazione o indifferenza essere donna purtroppo è un’aggravante.
Le donne capiscono fin da bambine quando è il momento di accelerare il passo e di tenere lo sguardo basso sul selciato. Sono atteggiamenti che si tramandano di madre in figlia, senza bisogno di verbalizzare: uno sguardo è più eloquente di mille parole, un cenno dipana dilemmi.
S’impara presto a rasentare i muri per evitare situazioni, a individuare l’angolo meno esposto nella ressa della metropolitana, a stare sedute con le gambe serrate e a far finta di non sentire se arriva un sussurro di troppo, magari condito da qualche oscenità.
In questa solitudine una donna è soprattutto “corpo”, perché è la sua dimensione fisica a essere passata al setaccio, a divenire oggetto fra altri oggetti da prendere, usare e gettare. Ed è un corpo di cui è doppiamente insicura, perché sa che è sempre naturale richiamo e perché scopre che in alcuni momenti potrebbe essere troppo esuberante.
Non dovrebbe essere così, e lo è sempre di meno. Nei nostri Paesi, cosiddetti civili e progrediti, le donne stanno imparando ad alzare la testa: “rallentano” il passo e non temono l’oscurità, si allontanano dai muri e non cercano più angoli dove andarsi a rintanare per evitare aggressioni fisiche o verbali, oppure situazioni imbarazzanti. Non temono più di essere solo corpo, ma sanno di essere persone.
Ma il “piccolo mondo antico patriarcale” che questi nostri stessi Paesi si portano dentro come un malefico retaggio è una tela di ragno vischiosa e si fa fatica a staccarlo di dosso. Quasi sempre sembra essere completamente sbiadito, a volte si rianima come uno zombie in un film dell’orrore e come uno zombie si muove e fa strage. A volte. Spesso, troppo spesso.
E poi c’è l’altra solitudine, quella non occasionale, quella ancora più pericolosa perché annidata subdolamente all’interno delle mura domestiche. La solitudine dell’anima, uno scaltro e continuo ricatto che promette abbandono.
La solitudine domestica è un equivoco crudele, un fraintendimento. Una tiranna alla quale paradossalmente si può finire per affezionarsi. Dispensa briciole d’amore, traveste le ostilità in forme di protezione, si insinua nelle parole e nei gesti concessi come premi o punizioni, soprattutto controlla i pensieri, li mette in gabbia e tarpa loro le ali.
E’ un tarlo mellifluo e conosce l’arte della manipolazione. Mentre persuade, allontana, emargina, colpevolizza, scava fossati tra chi così si fa preda e chi resta al di là capace di vivere una esistenza normale.
Dietro i vetri delle finestre, ostaggi di quella solitudine troviamo mogli, madri, sorelle e figlie. Donne che sanno soltanto guardare fuori senza trovare il bandolo della matassa, senza davvero avere il coraggio di uscire dal bozzolo malato della dipendenza emotiva e magari anche economica. E quando lo trovano, spesso, troppo spesso pagano un prezzo altissimo.
E chissà se poi la solitudine non sia anch’essa una forma di sottilissima violenza, se non sia in un certo senso questa la sua dimensione peggiore: invisibile e spietata. Come non pensare a quelle giovani madri che non riescono a trovare una posa “comoda” dentro lo scatto della famiglia felice. Oppure a quelle donne per le quali la maternità è una prova troppo difficile da superare proprio perché di essa percepiscono soprattutto il bagno della solitudine.
Chissà in quale momento preciso la solitudine diviene abbandono, trasformando il timore in terribile disperazione.

Immagine di apertura, Erik Johansson, Comfort zone, 2019